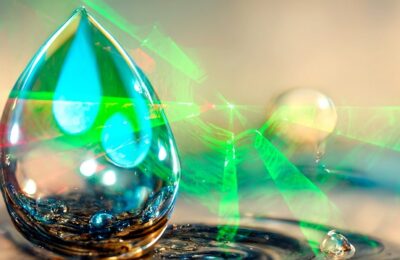Tobagi – Il 28 maggio 1980 veniva assassinato a Milano dalle Brigate Rosse il giornalista del “Corriere della sera” Walter Tobagi, una delle punte di diamante del giornalismo italiano, impegnato in temi sociali, politici e sindacali, e Presidente dell’ “ALG – Associazione Lombarda dei Giornalisti”.
Walter Tobagi aveva solo 33 anni e il suo impegno, giornalistico e sindacale, lo aveva portato ad essere una figura di spicco della stampa italiana, e questo lo pose nel mirino di un gruppo terroristico che fiancheggiava le Brigate Rosse, denominato “Brigata XXVIII Marzo”. Il giornalista sapeva, per le continue minacce che aveva ricevuto, che, prima o poi, sarebbe caduto nel mirino dei terroristi.

In una lettera del Natale 1978 così aveva scritto a sua moglie Stella: “…al lavoro affannoso di questi mesi va data una ragione, che io avverto molto forte: è la ragione di una persona che si sente intellettualmente onesta, libera e indipendente e cerca di capire perché si è arrivati a questo punto di lacerazione sociale, di disprezzo dei valori umani … per contribuire a quella ricerca ideologica che mi pare preliminare per qualsiasi mutamento, miglioramento nei comportamenti collettivi… Nell’Associazione … il motivo per cui mi sono addossato quella parte è un altro: un gesto di solidarietà verso quei colleghi, che considero anche amici, coi quali ho condiviso tante esperienze negli ultimi due anni. Un senso di solidarietà, un modo di non ragionare solo in termini di utilitarismo personale”. Nasce il 18 marzo 1947 a San Brizio, ma si trasferisce all’età di otto anni a Presso, in provincia di Milano a seguito di un trasferimento del padre ferroviere. Frequenta il liceo Parini di Milano e da redattore della storica “Zanzara” ne diventa in poco tempo il capo redattore. Si occupa già di temi culturali e di costume, argomenti che fanno già presagire i molteplici campi di interesse della sua successiva attività giornalistica. Entra dopo il liceo, giovanissimo, all’Avanti e successivamente all’Avvenire. Si delinea in quegli anni l’attenzione per i temi sociali, l’informazione, la politica e il sindacato. E’ poi Presidente dell’Associazione lombarda dei giornalisti a cui unisce anche l’impegno all’università come ricercatore nel campo dei movimenti sindacali socialista e cattolico. Successivamente arriva a lavorare al Corriere della Sera dove giunge presto ad occuparsi di vicende legate al terrorismo, sia nero che rosso, anche scrivendo libri su Alessandrini e su Feltrinelli, e seguendo i processi a Curcio, i casi di Toni Negri, del movimento del ‘77, di Prima Linea, dei primi pentiti, come Fioroni.
Al Corriere della Sera seguì sistematicamente tutte le vicende relative agli anni di piombo: dai tempi degli autoriduttori che disturbavano le Feste dell’Unità agli episodi di sangue più efferati che ebbero come protagonisti le Br, Prima Linea e le altre bande armate. Analizzando le vicende luttuose del terrorismo risaliva alle origini di Potere operaio, con la galassia delle storie politiche e individuali sfociate in mille gruppi, di cui molti approdati alle bande armate. In Vivere e morire da giudice a Milano Walter raccontò la storia di Emilio Alessandrini, sostituto procuratore della Repubblica, assassinato a 36 anni da Prima Linea in un agguato: un magistrato che si era particolarmente distinto nelle indagini sui gruppi estremisti di destra e, successivamente, su quelli terroristi di sinistra. Anche Alessandrini era un «personaggio simbolo». Scrisse Tobagi: «Alessandrini rappresentava quella fascia di giudici progressisti ma intransigenti, né falchi chiacchieroni né colombe arrendevoli». Osservò inoltre che i terroristi prendevano di mira soprattutto i riformisti, condividendo il giudizio che lo stesso Alessandrini aveva espresso in un’intervista all’Avanti!: «Non è un caso che le azioni dei brigatisti siano rivolte non tanto a uomini di destra, ma ai progressisti. Il loro obiettivo è intuibilissimo: arrivare allo scontro nel più breve tempo possibile, togliendo di mezzo quel cuscinetto riformista che, in qualche misura, garantisce la sopravvivenza di questo tipo di società». Un giudizio che doveva trovare una tragica conferma proprio con la uccisione di Tobagi. Negli ultimi articoli intensificò le analisi su certe realtà urbane a Milano, a Genova, a Torino («Come e perché un ‘laboratorio del terrorismo’ si è trapiantato nel vecchio borgo del Ticinese», «Vogliono i morti per sembrare vivi», «Bilancio di 10 miliardi all’anno per mille esecutori clandestini», ecc.). Non trascurò il fenomeno del pentitismo, con tutti gli aspetti anche negativi, e studiò il terrorista nella clandestinità, («C’è una regola dei due anni, termine ultimo oltre il quale non resiste il Br clandestino»). E siamo dunque a uno dei suoi ultimi articoli sul terrorismo, un testo che è stato ripubblicato molte volte perché considerato uno dei più significativi sin dal titolo: «Non sono samurai invincibili».
Tobagi sfatò tanti luoghi comuni sulle Br e gli altri gruppi armati, denunciando, ancora una volta, i pericoli di un radicamento del fenomeno terroristico nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro, come molti segnali gli avevano indicato. Scrisse, ad esempio: «La sconfitta politica del terrorismo passa attraverso scelte coraggiose: è la famosa risaia da prosciugare, tenendo conto che i confini della risaia sono meglio definiti oggi che non tre mesi fa. E tenendo conto di un altro fattore decisivo: l’immagine delle Brigate rosse si è rovesciata, sono emerse falle e debolezze e forse non è azzardato pensare che tante confessioni nascono non dalla paura, quanto da dissensi interni, sull’organizzazione e sulla linea del partito armato»
Le sue opinioni risultano confermate anche in un’altra significativa intervista al figlio di Carlo Casalegno, Andrea. In quell’intervista, concessa un mese prima dell’uccisione di Tobagi, Casalegno disse: «Non sento la benché minima traccia di odio, né provo alcun perdono cristiano. Sento l’offesa come nel momento in cui è avvenuta». L’intervistatore chiese se riteneva giusto denunciare i «compagni di lotta». E Andrea Casalegno rispose senza reticenze: «La denuncia è importante e va fatta se serve a evitare atti futuri gravi. È un dovere, perché è assolutamente necessario impedire che vittime innocenti cadano ancora». La sera prima di essere assassinato, Walter Tobagi presiedeva un incontro al Circolo della stampa di Milano. Si discuteva del «caso Isman» e dunque della libertà di stampa, della responsabilità del giornalista di fronte all’offensiva delle bande terroristiche. Il dibattito fu piuttosto agitato e l’inviato del Corriere fu fatto oggetto di ripetute aggressioni verbali, cosa non nuova, del resto, come ha raccontato il suo collega ed amico Gianluigi Da Rold: «Negli anni del suo impegno professionale e come responsabile sindacale dei giornalisti lombardi, Walter Tobagi viene violentemente attaccato, più di una volta, sia dalla parte comunista della redazione del Corriere, sia dai giornalisti di altre testate milanesi di cosiddetta “area comunista.”» A un certo punto, durante quel dibattito, Tobagi, riferendosi alla lunga serie di attentati terroristici, disse: «Chissà a chi toccherà la prossima volta». Dieci ore più tardi era caduto sull’asfalto sotto i colpi dei suoi assassini. Lasciava la moglie, Maristella, e due figli, Luca e Benedetta. Verso le 11.00 del 28 maggio 1980 Walter Tobagi, inviato sul fronte del terrorismo e cronista politico e sindacale del “Corriere della Sera”, era uscito dalla propria abitazione e si stava recando in garage per prendere l’auto. Fu affrontato e ucciso con cinque colpi di pistola da un commando di terroristi, uno dei quali sparò il colpo di grazia al giornalista che si era già accasciato a terra. Nel giro di alcuni mesi, le indagini portarono alla identificazione degli assassini, appartenenti alla “Brigata 28 marzo”, un gruppo terrorista di estrema sinistra, composto anche da figli di famiglie della borghesia milanese, costituitosi dopo l’uccisione di quattro appartenenti alle “Brigate Rosse” avvenuta a Genova, nel “covo di via Fracchia”, il 28 marzo di quello stesso anno. Le indagini accerteranno che da non poco tempo i terroristi avevano individuato Walter Tobagi quale “possibile obiettivo”. Al “Corriere della Sera” Tobagi aveva infatti seguito tutte le vicende relative agli “anni di piombo” e aveva denunciato il pericolo del radicamento del fenomeno nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro. Uno dei suoi ultimi articoli sul tema era intitolato “Non sono samurai invincibili”. La sera prima del suo omicidio aveva partecipato a un incontro al Circolo della stampa di Milano sul tema della responsabilità del giornalista di fronte all’offensiva delle bande terroristiche; riferendosi alla lunga serie dei loro attentati, aveva detto “Chissà a chi toccherà la prossima volta”. Dieci ore dopo cadde sotto i colpi dei suoi assassini.
Nel giro di pochi mesi dall’omicidio, le indagini di Carabinieri e magistratura portarono all’identificazione degli assassini, e in particolare a quella del leader della neonata Brigata XXVIII marzo, lo stesso Marco Barbone che, subito dopo il suo arresto, il 25 settembre 1980, decise di collaborare con gli inquirenti e grazie alle sue rivelazioni l’intera Brigata XXVIII marzo fu smantellata e furono incarcerati più di un centinaio di sospetti terroristi di sinistra, con cui Barbone era entrato in contatto durante la sua militanza terroristica. Le 102 udienze di quello che fu un maxi-processo all’area sovversiva di sinistra iniziarono il 1º marzo 1983 e terminarono 28 novembre dello stesso anno. La sentenza suscitò molte polemiche poiché il giudice Cusumano, interpretando la legge sui pentiti in modo difforme rispetto al Tribunale di Roma (dove furono irrogate comunque pene a oltre vent’anni di carcere ai terroristi pentiti delle Unità comuniste combattenti), concesse a Marco Barbone, Mario Ferrandi, Umberto Mazzola, Paolo Morandini, Pio Pugliese e Rocco Ricciardi «il beneficio della libertà provvisoria ordinandone l’immediata scarcerazione se non detenuti per altra causa», mentre agli altri membri della XXVIII marzo, De Stefano, Giordano e Laus, furono inflitti trent’anni di carcere. Le indagini non hanno chiarito il ruolo svolto dalla fidanzata di Marco Barbone, Caterina Rosenzweig, appartenente ad una ricca famiglia milanese, figlia dell’affarista Gianni e della preside Paola Sereni. Nel 1978, cioè ben due anni prima dell’omicidio, Caterina Rosenzweig aveva lungamente pedinato Tobagi, che era anche suo docente di Storia moderna all’Università Statale di Milano. Anche se nel settembre 1980 viene arrestata insieme con gli altri, Caterina verrà assolta per insufficienza di prove, nonostante nel corso del processo venga accertato che il gruppo di terroristi si riuniva a casa sua in via Solferino, a poca distanza dagli uffici dove lavorava Tobagi. Dopo il processo si trasferirà in Brasile, nazione in cui già aveva vissuto in quanto sede degli affari del padre, fino a far perdere le proprie tracce. Discussa fu la scelta da parte della magistratura di imbastire un processo con oltre 150 imputati e relativo non soltanto all’assassinio Tobagi ma a tutta l’area della sovversione di sinistra. Ciò, a detta di Ugo Finetti, segretario provinciale del PSI, ha fatto apparire il dibattimento come “un processo che sulla carta dovrebbe andare in scena perché si parli poco e male della vittima e con gli assassini più che altro messi sul banco non degli imputati, bensì degli accusatori, perché la sceneggiatura prevede che il centro dell’attenzione processuale riguardi altri fatti e altre persone”. Fu infatti scelto come referente privilegiato Marco Barbone, il quale, pentitosi subito dopo l’arresto, cominciò a fornire una notevole mole d’informazioni sugli ambienti della “lotta armata”. Tale scelta appare irrituale se si considera che il generale Carlo Alberto dalla Chiesa in un’intervista a Panorama rilasciata il 22 settembre 1980 (tre giorni prima dell’arresto del terrorista), fa cenno all’assassinio di Tobagi e alla Brigata XXVIII marzo e parla di aver « […] usato la stessa tecnica adottata a Torino nel ‘74-75 per la cattura di Renato Curcio: massima riservatezza, conoscenza anche culturale dell’avversario, infiltrazione». Ossia, le forze dell’ordine e la magistratura potevano già disporre di una serie d’informazioni relative al gruppo terroristico e al delitto. Nonostante ciò, come già detto, durante il dibattimento ci si basò sulle dichiarazioni di Barbone, il quale non fu arrestato come sospetto per l’omicidioma con i seguenti capi d’accusa: appartenenza alle FCC, a Guerriglia rossa e partecipazione alla rapina ai Vigili urbani di via Colletta. Nella stessa intervista il generale afferma che vi sono sostenitori della Brigata XXVIII marzo tra i giornalisti. Altra stranezza è la insolita uniformità di punti di vista tra PM e difesa di Barbone e la contrapposizione, altrettanto insolita, tra accusa e parte civile, la quale si vide rifiutare ogni istanza tesa a chiarire le dinamiche del delitto e le circostanze che portarono Barbone a pentirsi. Nel documento di rivendicazione del delitto i terroristi sembrano essere a conoscenza dei fenomeni legati al mondo della stampa e a particolari relativi alla vita professionale di Tobagi; del giornalista scrissero «preso il volo dal Comitato di redazione del Corsera dal 1974, si è subito posto come dirigente capace di ricomporre le grosse contraddizioni politiche esistenti fra le varie correnti», ma Gianluigi Da Rold si chiede: «Come fanno a sapere che Walter Tobagi fece parte del comitato di redazione del Corsera (termine usato solo all’interno di via Solferino) quale rappresentante sindacale del «Corriere d’informazione» anche se per poco tempo, due mesi,, nel 1974?» Il comitato di redazione del Corsera non è da confondere con l’omologo del Corriere della Sera; vi si riunivano i rappresentanti delle redazioni di tutti i quotidiani e periodici allora collegati alla testata milanese. Nel testo, quindi, si cita un fatto molto particolare, ma Barbone, durante il dibattimento, afferma di essersi confuso: riprendendo un articolo di Ikon, ci si sarebbe sbagliati e scritto 1974 anziché 1977, l’anno in cui Tobagi entrò effettivamente a far parte del comitato di redazione del quotidiano. Ma, come detto, il comitato di redazione del Corriere della sera è cosa diversa da quello del Corsera e appare strano che, laddove l’autore del testo (o gli autori, stando alla versione fornita da Barone) appare consapevole della differenza, nella sua dichiarazione al processo dimostra di non averla ben presente, affermando di essersi semplicemente confuso sulla data di ingresso di Tobagi nel comitato di redazione del «Corriere della sera». Altra incongruenza nelle dichiarazioni di Barbone è quella relativa al suo pedinamento del giornalista la notte del 27 maggio, il giorno prima del delitto. Nel mese di maggio del 1980, la vittima si assentò spesso da Milano per seguire la campagna elettorale per le amministrative, e tornava solo la domenica. Il 27, un mercoledì, eccezionalmente era presente al “Circolo della stampa” di Milano (dove fu oggetto, come riferiscono i testimoni, di attacchi verbali). Il terrorista, successivamente, affermò di aver girato con l’auto attorno alla sede dell’associazione «per rintracciare eventualmente quella del Tobagi e avere conferma che ci fosse, ma senza averla vista, me ne andai subito. La mattina successiva, quindi, agimmo». Se la presenza dell’auto presso il circolo era un fatto secondario rispetto alla messa in pratica del disegno criminoso, allora perché Barbone decise di pedinare Tobagi e soprattutto, come seppe della sua presenza a Milano?
In via Salaino, a Milano, all’angolo con via Solari, nei pressi del luogo dell’omicidio, il 28 maggio 2005 è stata posta una targa in sua memoria dalla Giunta comunale di Milano, accogliendo la richiesta dell’Associazione Lombarda Giornalisti, di cui Tobagi era presidente, e dell’Ordine del Giornalisti della Lombardia, ha deciso di ricordarlo nel venticinquesimo anniversario della morte. Nella targa è riportato un passo di una lettera che Tobagi scrisse nel dicembre del 1978 alla moglie: «… al lavoro affannoso di questi mesi va data una ragione, che io avverto molto forte: è la ragione di una persona che si sente intellettualmente onesta, libera e indipendente e cerca di capire perché si è arrivati a questo punto di lacerazione sociale, di disprezzo dei valori umani (…) per contribuire a quella ricerca ideologica che mi pare preliminare per qualsiasi mutamento, miglioramento nei comportamenti collettivi.»
Il figlio Luca il 28 Maggio del 2016 scrisse sul padre: “Il senso di responsabilità sociale di mio padre aveva dimensione pubblica, ma era esercitato nella forma privata del suo impegno. Le sue opinioni non dovevano intaccarne professionalità e indipendenza intellettuale, il suo patrimonio più grande, né interferire con la capacità di svolgere il suo lavoro in modo credibile e scrupoloso. Questo è stato il modo «politico» di spendere i suoi talenti: non proclami, toni urlati, immagine, schieramento da tifoso, ma lavoro tenace, costante, di qualità, e decisioni personali anche costose, prese con discrezione, quando è stato necessario. Espressioni vaghe, come «società civile» (usata due volte nel 1980, e prima solo una in contrapposizione al dittatore Franco e una nel virgolettato di un intervistato) o «valori non negoziabili», non hanno trovato spazio nei suoi articoli. È dai comportamenti che si distinguono la civiltà e i valori. Messaggio valido anche oggi che lo stile è molto diverso da quello che mio padre sceglierebbe e l’uso delle parole, in un contesto di tensioni diffuse, meriterebbe la stessa ponderazione che lui aveva riservato, nel 1979, a ciò che purtroppo non rimase «un futile gioco di salotto». «Impegno» e «merito». Dei temi economici, del lavoro, del sindacato, mio padre ha scritto molto. Ha anche assunto incarichi e iniziative per rappresentare i giornalisti. Proprio per l’importanza che attribuiva al lavoro e alle vertenze che lo riguardavano, cercava di darne resoconti e valutazioni obiettivi. «Gli scioperi di pochi che colpiscono molti» è un titolo che ha guadagnato attualità nei suoi 33 anni di vita. Il tema dell’accesso e del diritto al lavoro era per lui inscindibile da impegno, merito e competenza. Rimane per me memorabile, in un articolo del 1975 di denuncia dello scandalo delle raccomandazioni, l’immagine di una scheda ministeriale per archiviare le segnalazioni. La parola centrale, però, è «persona». Mio padre ne intervistò moltissime, di ogni estrazione sociale e posizione politica. Tali ritratti riflettono la convinzione della centralità degli individui, di scelte, impegno e responsabilità dei singoli: la società è importante e sono le persone, con le proprie azioni, a farla. Le pressioni esterne non giustificano, da sole, i comportamenti individuali. Per capire la società, quindi, doveva conoscere le persone, dal leader politico allo studente, dall’operaio al capitano d’industria. Mi ha sempre colpito la «storia di una donna che faceva i panettoni»: problemi e sentimenti quotidiani, diretti, ineludibili, come il «chi è dunque che ci ha colpa?» di manzoniana memoria. Se mio padre fosse vivo, oggi, esorterebbe i miei figli e i loro coetanei a guardarsi attorno con occhi curiosi. A ragionare sul mondo e spiegare, almeno a se stessi, anche ciò che appare più difficile da capire, sapendo che capire non significa accettare. Ad agire per il bene, con un impegno serio, senza clamore. A far emergere quell’umanità che sta dentro di noi e intorno a noi e che proprio per questo, forse, è più difficile portare in superficie.