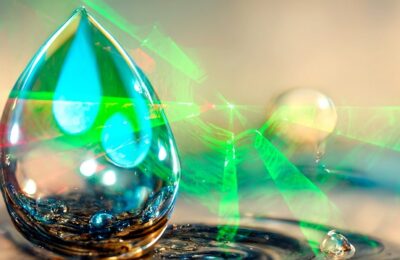Berlinguer – II 7 Giugno 1984, durante un comizio a Padova, sul palco di Piazza della Frutta, il leader del PCI Enrico Berlinguer viene colpito da un malore.
Quel 7 Giugno 1984
Durante l’intervento venne colpito da un ictus che lo costrinse a una pausa mentre si apprestava a pronunciare la frase: «Compagni, lavorate tutti, casa per casa, strada per strada, azienda per azienda.»
Pur palesemente provato dal malore, continuò il discorso fino alla fine, nonostante anche la folla, dopo i cori di sostegno, urlasse: «Basta, Enrico!». Alla fine del comizio rientrò in albergo, dove si addormentò sul letto della sua stanza, entrando subito in coma. Dopo il consulto con un medico, venne trasportato all’ospedale Giustinianeo e ricoverato in condizioni drammatiche. Morì l’11 giugno a causa di un’emorragia cerebrale. Il comunicato del sovrintendente sanitario affermò che il politico sardo era venuto a mancare alle 12:45.

PERTINI AL CAPEZZALE
Il presidente della Repubblica Sandro Pertini, che si trovava già a Padova per ragioni di Stato, si recò in ospedale per constatare le condizioni di Berlinguer. Fece in tempo a entrare in stanza per vederlo e baciarlo sulla fronte. Si impose, poche ore dopo il decesso, per trasportare la salma sull’aereo presidenziale, dicendo: «Lo porto via come un amico fraterno, come un figlio, come un compagno di lotta». Commovente fu il suo saluto al funerale, il 13 giugno, al quale partecipò circa un milione di persone: il presidente si chinò con la testa sopra la bara, baciandola tra gli applausi dei presenti.
Sonori fischi, che ricambiavano quelli subiti da Berlinguer al congresso socialista, si levarono invece quando Nilde Iotti citò il presidente del Consiglio Bettino Craxi, al quale precedentemente era stata impedita da Marco Berlinguer la visita al capezzale del padre. Anche coloro che erano in assoluto politicamente più distanti da Berlinguer, ovvero Giorgio Almirante e Pino Romualdi, rispettivamente segretario e presidente del Movimento Sociale Italiano, riconoscendo il rigore morale dell’avversario, parteciparono al funerale.
Il corteo con la bara, accompagnato dalla musica dell’Adagio in sol minore di Remo Giazotto, sfilò dalla sede del PCI, in via delle Botteghe Oscure, a piazza San Giovanni, rendendo palese l’ammirazione che una larga parte dell’opinione pubblica italiana aveva nei confronti di Enrico Berlinguer.
Le imminenti elezioni europee, anche in ragione dell’ondata emotiva determinata dalla morte del leader comunista, videro un grande successo del PCI che, per la prima e unica volta nella storia, superò la DC, affermandosi come primo partito italiano (33,3% contro 33,0%); Berlinguer, candidato nella circoscrizione centrale, ottenne oltre 710 mila voti di preferenza (a fronte degli 836 mila conseguiti alle europee di cinque anni prima. Per evocare la forte ascesa del PCI, si è a lungo parlato di “effetto Berlinguer”, sebbene una parte degli osservatori politici e alcuni esponenti del partito avessero negato che il successo elettorale fosse da ricondurre alla scomparsa del segretario.
Per decisione della famiglia, secondo la volontà espressa alla moglie, Berlinguer è stato sepolto a Roma nel Cimitero di Prima Porta, nonostante il Partito desiderasse che fosse tumulato al Cimitero del Verano, nel mausoleo in cui già riposavano i dirigenti comunisti Palmiro Togliatti, Giuseppe Di Vittorio e Luigi Longo e dove nel 1999 sarebbe stata sepolta anche Nilde Iotti.
BERLINGUER LA STORIA
Enrico Berlinguer nasce il 25 maggio del 1922 a Sassari. Nella cittadina sarda trascorre l’infanzia e l’adolescenza, frequenta il liceo classico Azuni e nel 1940 si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza. Nell’agosto del 1943 aderisce al PCI. Inizia allora il suo impegno politico con la partecipazione alle lotte antifasciste dell’Italia badogliana dove impera la guerra civile. Nel gennaio del 1944 viene arrestato con l’accusa di essere il principale istigatore delle manifestazioni per il pane, che si sono svolte nei mesi precedenti. Resta in carcere quattro mesi. A settembre si trasferisce a Roma con la famiglia, poi a Milano dove lavora nel Fronte della gioventù, il movimento politico fondato da Eugenio Curiel per coordinare l’arcipelago delle organizzazioni giovanili antifasciste.
La sua carriera politica nel PCI comincia nel gennaio del 1948, quando a ventisei anni entra nella direzione del partito e meno di un anno dopo diventa segretario generale della FGCI, la Federazione giovanile comunista. È un uomo instancabile che gli amici descrivono timido e introverso. Un giovane dirigente comunista, lontano dalla mondanità e dai clamori della politica, che nel 1956 lascia l’organizzazione giovanile e l’anno dopo sposa a Roma Letizia Laurenti.
Nel 1958 Berlinguer entra nella segreteria del partito per affiancare Luigi Longo, vicesegretario e responsabile dell’ufficio di segreteria. Da allora il rapporto fra Berlinguer e il segretario Togliatti diviene quotidiano. Togliatti si fida di questo giovane dirigente sardo, tanto che nel febbraio del 1960, al IX Congresso del PCI, lo vuole al posto di Giorgio Amendola come responsabile dell’organizzazione del partito e nel dicembre del 1961 chiede a Berlinguer di scrivere la relazione finale del comitato centrale del partito, dove proprio Amendola ha ripreso la polemica sui crimini stalinisti.
Fra il 1964 e il 1966 Berlinguer mostra la sua grande capacità di mediare gestendo un grosso scontro interno al partito. La destra del PCI, rappresentata da Amendola, sostiene la formazione di un unico partito socialista che unisca tutte le forze della sinistra italiana. L’ala radicale di Pietro Ingrao, invece, si batte affinché il PCI si allei con i gruppi della sinistra rivoluzionaria.
All’XI Congresso, nel gennaio del 1966, Berlinguer si fa interprete delle esigenze di tutto il partito presentandosi come un mediatore di prima grandezza. È un successo personale, confermato due anni dopo dalle elezioni del 1968 in cui è capolista nel Lazio. Un successo che esplode e si diffonde dopo i fatti di Praga. Berlinguer condanna l’intervento sovietico in Cecoslovacchia e respinge «il concetto che possa esservi un modello di società socialista unico e valido per tutte le situazioni». Lo strappo è senza precedenti.
Nel 1969 a Mosca, alla conferenza internazionale dei partiti comunisti, dichiara apertamente il dissenso dei comunisti italiani nei confronti della politica stalinista.
Ormai è vicesegretario del PCI. Al congresso del 1969, Berlinguer appoggia la linea movimentista e introduce uno dei temi più importanti del suo progetto politico. Ai delegati presenta il partito come una forza centrale della società italiana, una forza fra le istituzioni e i cittadini, che deve essere coinvolta nella formazione e nella gestione dei processi democratici del paese perché ne è parte decisiva. Il PCI che vuole Berlinguer non è solo il partito della classe operaia: deve candidarsi a guidare il paese, ponendo fine alla conventio ad excludendum per cui i comunisti di fatto sono esclusi dal governo.
Nel 1972 Berlinguer diviene segretario del PCI e al XII congresso riprende la formula togliattiana della collaborazione fra le grandi forze popolari: comunista, socialista e cattolica. Ma c’è anche di più, non si tratta solo di ribadire la tesi che Togliatti espresse sin dalla fine della seconda guerra mondiale. Con tre articoli su «Rinascita», fra il settembre e l’ottobre del 1973,
Berlinguer propone la sua analisi della società moderna partendo dal colpo di Stato in Cile, che ha mostrato a cosa può andare incontro una democrazia fragile. Così scrive il 12 ottobre del 1973: «la gravità dei problemi del paese, le minacce sempre incombenti di avventure reazionarie e la necessità di aprire finalmente alla nazione una sicura via di sviluppo economico, di rinnovamento sociale e di progresso democratico rendono sempre più urgente e maturo che si giunga a quello che può essere definito il nuovo grande compromesso storico tra le forze che raccolgono e rappresentano la grande maggioranza del popolo italiano». Lo spiega chiaramente. L’Italia è una democrazia debole che ha bisogno di un’alternativa condivisa e costruita dai grandi partiti di massa.
Il grande successo elettorale, ottenuto dai comunisti italiani alle elezioni del 1975 e del 1976, conferma l’intuizione di Berlinguer e sconvolge il sistema politico, ormai da anni afflitto da un’endemica instabilità e bloccato dalla DC che è al centro dei governi e delle maggioranze parlamentari. I tempi sembrano maturi per un cambiamento radicale della politica italiana.
Nel 1976 accanto alla proposta del compromesso storico, Berlinguer esplicita l’altro tema della sua politica di dirigente comunista: rompe con il Partito Comunista sovietico. A Mosca, davanti a 5 mila delegati Berlinguer parla del valore della democrazia e del pluralismo, sottolinea l’autonomia del PCI dall’URSS e condanna l’interferenza dei sovietici nelle questioni dei partiti socialisti e comunisti degli altri paesi. È l’eurocomunismo.
Con il compromesso storico e l’eurocomunismo, Berlinguer porta il PCI, dopo le elezioni del 1976, al primo governo della solidarietà nazionale. Si tratta di un monocolore democristiano che si regge sulla «non sfiducia», cioè sull’astensione dei vecchi partners di governo ai quali si aggiungono i comunisti. A sinistra, molti sottolineano che non è questa la ratio del compromesso storico e che il PCI non riuscirà ad ottenere ciò che ha chiesto ai democristiani in cambio della non sfiducia. E, infatti, le elezioni del 1977 non lo premiano.
Nel gennaio 1978 Berlinguer incontra Aldo Moro, il leader democristiano con cui ha costruito il governo della solidarietà nazionale e gli chiede di agevolare l’entrata dei comunisti al governo. Ma ad opporsi sono in molti: la destra democristiana, il Vaticano, gli amici americani, la destra italiana. E intanto nel paese il terrorismo miete le sue vittime; due mesi dopo le BR rapiscono e uccidono Moro. È la fine della solidarietà nazionale e del progetto di Berlinguer. Il PCI torna all’opposizione.
Nel 1981, in un’intervista a Eugenio Scalfari, Berlinguer accusa la classe politica italiana di corruzione, sollevando la cosiddetta questione morale. Denuncia l’occupazione da parte dei partiti delle strutture dello Stato, delle istituzioni, dei centri di cultura, delle Università, della Rai, e sottolinea il rischio che la rabbia dei cittadini si trasformi in rifiuto della politica.

Su Berlinguer si potrebbero scrivere tante cose grazie ai racconti di chi ha vissuto la politica dei suoi anni.
Nel Giugno del 1983 sul Manifesto parlando di politica di sinistra disse: “È necessario un grande sforzo culturale, rispetto al quale la sinistra è in ritardo, in ritardo nelle idee e negli strumenti di conoscenza e di intervento. Ci sono deformazioni della vita associata, e degenerazioni dell’organizzazione statale, che la cultura di destra legittima e perfino esalta come risvolti dello sviluppo, della modernità, del libero mercato, del successo individuale.
Sono i connotati negativi del sistema che finiscono con l’entrare nel senso comune. Negli Stati Uniti c’è un’ondata «creazionista», antidarwiniana, a cui partecipa Reagan in persona, che funziona da travestimento ideologico dell’individualismo e del capitalismo, una nuova etica.
La sinistra ha fatto bene a disfarsi di vecchi miti, a riaffermare la sua piena laicità, ma non può vivere e vincere senza valori ideali, che sono poi quelli di cui il movimento operaio è portatore da sempre – pace, giustizia, eguaglianza, lavoro, sapere, solidarietà – ma che hanno bisogno dì essere diversamente pensati e tradotti, perché si applicano a una realtà diversa. Devono ridiventare anch’essi senso comune”.
LA GENTE PER BERLINGUER
Parlando dei problemi della gente, al Comitato Centrale del Pci, gennaio 1981 aveva detto: “C’è troppo squilibrio tra ciò di cui ci occupiamo noi, a tutti i livelli, e ciò che interessa quotidianamente la gente. Se non si fa fino in fondo questa correzione, diventa vaniloquio la lotta contro il sistema di potere della Dc, contro le clientele, contro i ricatti politici degli altri partiti, ossia la lotta per fare affermare la nostra proposta che deve basarsi su una costante iniziativa di massa e che deve riuscire a realizzare effettivi spostamenti nei rapporti di forza”
Nel Febbraio del 1976, aveva parlato in parlamento della crisi morale: “.. Io non voglio tornare a insistere sulle cause politiche della crisi morale. Mi preme dire che tale crisi ci riconduce certo al problema politico di fondo; che la verità è che i malanni e i guasti più rilevanti – quelli del sottogoverno, del clientelismo, delle spartizioni del potere, delle confusioni tra pubblico e privato, delle commistioni tra potere politico e potere economico, dell’inceppamento dei meccanismi del controllo democratico, dell’abitudine all’impunità – sono stati il portato di una organizzazione del potere fondata per lungo tempo sulla discriminazione anticomunista, sul monopolio e il predominio della Democrazia cristiana, sulla dichiarata impossibilità di una qualche alternativa a quel tipo di regime, sia nel periodo centrista sia in quello del centrosinistra.
Che da questo tipo di direzione politica e dal tipo di sviluppo economico siano derivati i processi degenerativi che hanno finito col coinvolgere la stessa Democrazia cristiana, non mi par dubbio.
Tuttavia, non si tratta di pronunciare sommarie condanne moralistiche. E certo però che siamo di fronte a un decadimento, a una perdita di autorità politica e morale dei gruppi dirigenti; e siamo di fronte al rischio che in qualche misura sia offuscato quel cardine della democrazia costituito dal sistema dei partiti, e quella conquista della Resistenza che fu la costruzione dei grandi partiti democratici di massa.
Per questo, l’esigenza della moralizzazione della nostra vita pubblica e di un recupero di valori, appare oggi così forte e ripropone quella svolta politica, quel ricambio e rinnovamento della classe dirigente per cui è essenziale il Partito comunista”.

BERLINGUER E LA QUESTIONE MORALE
Nel Giugno 1984 sulla questione morale aggiunse: “. Ormai tutti vedono che le coalizioni che prendono vita alle spalle del Parlamento, che i governi che non vogliono e non sanno governare con e attraverso il Parlamento, che sono il prodotto di questi meccanismi e di questi metodi consunti, e divenuti anche pericolosi, non sono coalizioni realmente solidali ed efficienti. I partiti delle maggioranze delimitate che compongono quelle coalizioni stanno insieme al governo spalleggiandosi per poter conservare il loro potere sulle istituzioni e sulla società, ma ciascuno è dominato dalla paura che un altro lo scavalchi.
E allora si va alle ben note «verifiche», dopo le quali, tuttavia, quelle coalizioni restano egualmente divise, continuano a covare contrasti, dai quali possono venire o oscillazioni, incertezze e paralisi dei governi, ovvero polemiche e lacerazioni: queste ultime, però, esplodono per lo più fuori del Parlamento (negli organi di partito, nei convegni, sulla stampa).
Nel Parlamento esse o vengono artatamente coperte e dissimulate o si manifestano nella forma patologica dei «franchi tiratori». Si corre, allora, ai ripari; ma, ancora una volta, i rimedi a cui si pensa vanno prevalentemente in direzione di un indebolimento dei poteri del Parlamento.
Sicché la profonda esigenza di restituire alle istituzioni la funzionalità e il ruolo che spetta loro in una Repubblica democratica a base parlamentare viene distorta e tradita. Attraverso alcune delle «riforme» di cui si sente oggi parlare si punta a piegare le istituzioni, e perciò anche il Parlamento, al calcolo di assicurare una stabilità e una durata a governi che non riescono a garantirsele per capacità e forza politica propria. Ecco la sostanza e la rilevanza politica e istituzionale della «questione morale» che noi comunisti abbiamo posto con tanta decisione.
Anche la irrisolta questione morale ha dato luogo non solo a quella che, con un eufemismo non privo di ipocrisia, viene chiamata la Costituzione materiale, cioè quel complesso di usi e di abusi che contraddicono la Costituzione scritta, ma ha aperto anche la strada al formarsi e al dilagare di poteri occulti eversivi (la mafia, la camorra, la P2) che hanno inquinato e condizionano tuttora i poteri costituiti e legittimi fino a minare concretamente l’esistenza stessa della nostra Repubblica.
Di fronte a questo stato di cose, di fronte a tali e tanti guasti che hanno una precisa radice politica, non si può pensare di conferire nuovo prestigio, efficienza e pienezza democratica alle istituzioni con l’introduzione di congegni e di meccanismi tecnici di dubbia democraticità o con accorgimenti che romperebbero anche formalmente l’equilibrio, la distinzione e l’autonomia (voluti e garantiti dalla Costituzione) tra Legislativo, Esecutivo e Giudiziario, e accentuerebbero il prepotere dei partiti sulle istituzioni. Riforme delle istituzioni volte a ridare efficienza e snellezza al loro funzionamento sono certo necessarie.
Ma esse a poco servirebbero se i partiti rimangono quello che sono oggi, se seguitano ad agire e a comportarsi come agiscono e si comportano oggi, se non si risanano, se non si rigenerano, riacquistando l’autenticità e la pienezza della loro autonoma funzione verso la società e verso le istituzioni.
Altrimenti, a che cosa si va incontro è facile prevederlo oggi, più di quanto non lo prevedesse già venti anni fa Togliatti, nel suo ultimo discorso alla Camera, due settimane prima di morire. In quell’occasione, riferendosi all’Italia e all’Europa, egli constatava «la tendenza alla limitazione progressiva delle istituzioni democratiche e all’autoritarismo”