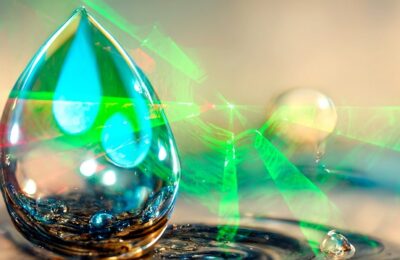Himalaya-Approfondendo alcuni contenuti sulle gesta dei nostri alpinisti nel mondo mi sono imbattuto in una storia tutta da raccontare, una di quelle circostanze sconosciute ai più che sono un esempio della dedizione e del senso del dovere di alcuni rappresentanti del popolo italiano. A Yol, “vasta pietraia ai piedi di un contrafforte (M.Nodrani) della catena himalayana del Dhaola Dhar, nella Valle del Kangra, che allora apparteneva alla provincia inglese del Punjab e oggi all’Hindustan”, c’era un campo di concentramento inglese con centinaia di prigionieri italiani. Geograficamente siamo oggi tra le regioni dello Jammu, Kashmir e l’Himachal Pradesh (vallate che oggi sono diventate località turistiche e meta di escursioni alpinistiche). A raccontarlo nel volume “Alpinismo Italiano nel Mondo”, edito nel 1953 dal CAI e dal TCI, è Quirino Maffi, collaboratore di lunga data dell’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente, traduttore, scrittore, giornalista e viaggiatore.

“Verrei meno alla necessaria cautela del cronista se dicessi che l’autorità che ci deteneva (nella fattispecie l’autorità militare britannica) s’era resa conto del nostro fondamentale buon senso, o senso della misura che dir si voglia. Osserverò invece che Yol è talmente fuori dal mondo, che le sullodate autorità avevano potuto allentare man mano il normale rigore disciplinare nei confronti di noi detenuti; cosicché nel settembre 1943 non ci parve assurdo chiedere – e non ci fu difficile ottenere – il permesso di compiere due escursioni di 7 giorni sulla catena del Dhaola” scrive Maffi, che continua nella narrazione: “Il permesso ci impegnava, sulla parola d’onore, ad andare in una determinata direzione (nord), a rispettare numerose limitazioni e a rientrare al “chiuso” entro il giorno fissato. Cosicché eccoci, sventolando il nostro permesso, a tu per tu con la superba muraglia del Dhaola Dhar, che ci sovrastava di tre-quattromila metri a picco”. E così salirono la loro montagna raggiungendone la cresta finale in due punti attorno ai 4600m.
Inizia una straordinaria avventura alpinistica pressoché sconosciuta e dimenticata che partendo dai primi due permessi coinvolgerà nell’anno successivo quasi 600 prigionieri italiani.
Gli alpinisti prigionieri sono un gruppo omogeneo dei più appassionati e forti e iniziano a organizzarsi costruendo con barattoli, rottami di ferro, teli cerati e avanzi di stoffa la loro attrezzatura di montagna: piccozze, scarpe chiodate, ramponi, sacchi a pelo e indumenti pesanti. Accumulano viveri durante la stagione non propizia risparmiando sulle misere razioni da prigionieri e racimolare i pochi soldi che servono per reclutare qualche portatore fanno colletta e piccoli lavori per gli inglesi che “potevano dormire fra due guanciali mentre noi ci arrampicavamo per la montagna”.
L’attività alpinistica di questi uomini era ispirata da “alcune cose che sono il sale, il senso, la misura della nostra avventura himalayana”: i rigidi limiti temporali, di mezzi e di spazio sono suppliti da uno slancio individuale che l’autore definisce “follia (della serena varietà italica) o ansia di vita e di libertà”. C’è persino il “vecio” alpinista, il tenente colonnello degli alpini Giuseppe Bedetti, che sfidando il divieto inglese fabbricava, beveva e vendeva grappa per dare una mano e accompagnare i giovani prigionieri sulle montagne, di cui ne apprezzava la compagnia, ma che non ne sapeva godere. “Pareva un vecchio tronco; e si spezzò di schianto come i vecchi tronchi. Lui solo dei 600 prigionieri che s’avventurarono sull’Himalaya del Punjab in quegli anni, non tornò in Italia” si legge.
Dal 1943 al 1946 gli alpinisti italiani del Yol si cimentarono sul Dhauladhar e su una serie di vette interessanti scrivendone la unica storia alpinistica. Alcuni nomi vennero dati dalla “squadra Bandera”, un gruppo particolarmente attivo di cui facevano parte: Bandera Otto di Vicenza, Borzini da Torino, Margaria da Cuneo, Valenti da Pavia, e Vassallo da Milano. Li voglio citare perché è importante che almeno alcuni dei nomi di questi incredibili alpinisti himalayani vengano riscritti e ricordati.
Cima Otto (4981m); Guarijunda (5287m); Lena (4807m) “che dovremmo chiamarla piuttosto Cervino… per l’analogia delle sue linee con quelle del colosso alpino”. Dhar Narwana (4690m); Two Guns Peak o Deo Peak (4570m), nome appioppato da un ufficiale d’artiglieria inglese, l’unico segno lasciato dai britannici su quelle montagne. Mentre Franco Seniglia e Renato Venuti vi tracciarono un bell’itinerario per il versante nord.
Il Pangi Range tra il 1944 e 1945 fu la meta di escursioni di più lunga durata, 15 giorni di libertà. Oggi questa regione è una località turistica montana indiane parecchio visitata e mi si contorce l’anima a pensare che l’attività alpinistica del tutto esplorativa di questi nostri alpinisti/prigionieri sia così dimenticata. Oggi queste regioni sono meta di trekking e spedizioni alpinistiche indiane e internazionali, ma gli occhi che videro per primi l’alpinismo su quelle montagne furono italiani. Così tra il 1943 e il 1946 furono saliti da più itinerari il Laluni (6032m), il Kuja-ka- Tilla (5447m) e furono raggiunti e visitati molti passi e valli proprio da Quirino Maffi con l’amico Soncini.
La Grande catena dell’Himalaya fu visitata dai nostri connazionali principalmente nel 1945. Le regioni del Parbati-Kulu- Lahoul avrebbero richiesto più tempo e così gli alpinisti/prigionieri italiani chiesero permessi di 30 giorni, che furono accordati. Così salirono montagne di tutto rispetto come il Deo Tibba (5965m); il Mulkillà (6517m), che era stato salito da una spedizione austrica nel 1939; Cima Italia (6166m), salita il 2 luglio del ‘45 dal gruppo di cui facevano parte Basso Pietro, Camilleri Luciano, Campello Giovanni, Carrega Pietro ,Celi Pietro, Cascia Mauro, Cuoco Gaetano, De Micheli Franco, Fichera Antonio, Fois Giuseppe, Fundaro Massimo, Lucchetta Giuseppe, Maggiulli Adolfo, Verga Andrea e Vuxani Giorgio.
“Nella nostra avventura himalayana – conclude Quirino Maffi-, c’è un elemento che difficilmente si potrà ritrovare in altre: ed è il carattere collettivo della nostra attività alpinistica. Collettivo non tanto nel senso numerico, quanto nel senso di una fraterna intesa fra coloro che vi parteciparono. Non abbiamo detto, ad esempio, quante volte, mancando i portatori indigeni (e mancando i soldi per ingaggiarli), squadre di volontari lietamente si sacrificavano a portare i carichi, affinché altri, più qualificati, potessero affrontare le cime in condizioni di maggiore freschezza. Dobbiamo anche dire che l’intesa fraterna d’allora s’è conservata, fra noi… basta guardarci negli occhi per ritrovare, l’uno nell’altro, un senso vigoroso e schietto di solidarietà, quasi che l’esperienza d’allora abbia sciolto, o reso trasparente, il guscio in cui l’uomo si chiude. In questo senso almeno, se non in altri, noi sappiamo di essere stati degli alpinisti veri e di aver onorato la nostra Patria e la Montagna”.