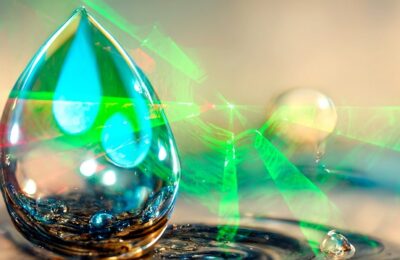Nassyria – Sono trascorsi 17 anni ma quel giorno è nella mente e nei cuori di chi ama la difesa e lotta e si impegna per la propria Nazione. Quel tragico giorno uomini, servitori dello Stato, in servizio in Iraq furono barbaramente uccisi mentre erano intenti ad aiutare il popolo sofferente. Il terrorismo colpì duro l’Italia e gli italiani “veri”. Oggi si ricorda questa data con l’affetto verso le famiglie di quelle vittime e per i loro cari che hanno perso la vita mentre lavoravano per la pace in un paese straniero.

Per l’occasione ecco la testimonianza di Massimiliano Esposito, presente in quelle ore a pochi chilometri da quel vile attentato.
“Oggi è il 12 Novembre, 18 anni fa subivamo la più grande strage terroristica per il nostro Paese: scattava il nostro “11 Settembre”. A Nassirya – Iraq morivano sotto la violenza suicida kamikaze, 19 italiani.
Ore 10.40 una telefonata arriva all’ospedale da campo Role2+ di Tallil dove ero di servizio, avevo poco più di 19 anni… Un trillo di telefono, alzo la cornetta e una voce grida senza lasciarmi lo spazio di replica:
«C’è stato un attentato, venite qui che è l’inferno». Scatto in piedi, non ho il tempo di ragionare, è successo ciò di cui più avevo timore. Solo il tempo di avvisare il Direttore che già sono sulla mia ambulanza a sirene spiegate, preparo tutto ciò che può essermi utile «cazzo ho studiato mesi e mesi prima di metter piedi qui, storia, tradizioni, territorio, amalgama con esercito americano, inglese, albanese, rumeno e bulgaro». So cosa fare, lo so fare bene – indosso il giubbotto antiproiettile, carico il fucile, colpo in canna e adrenalina a mille. Non lo so in quel momento, ma sto per metter piede nel luogo più tragico della storia militare e non, italiana, degli ultimi 100 anni.
Arrivo sul luogo dello scoppio poco dopo, la base MSU “Maestrale” è stata sventrata, è lì ad appena cinque chilometri da noi, meno di 10 minuti di strada dal mio compound. Un viaggio interminabile dovuto allo studiato ostruzionismo di auto civili con l’intento di far arrivare i soccorsi più tardi possibile per far più morti.
Oltre 300 chili di tritolo, un auto cisterna usata come ariete, “solo” 28 i morti di cui 19 italiani, ma potevano essere molti di più. Il carabiniere Andrea Filippa, di guardia all’ingresso della base principale, riuscì a uccidere i due attentatori, tant’è che il camion non esplose all’interno della caserma ma sul cancello di entrata, evitando così una strage di più ampie proporzioni.

Sono il primo, scendo e come se fossi stato catapultato in una scena di “Apocalypse Now” mi trovo all’inferno. Mezzi in fiamme, fumo, gente che si dispera o che esulta come se fosse allo stadio, non ci capisco più di tanto, la confusione regna sovrana, ma un uomo in divisa mi indica il VM – un mezzo blindato in dotazione all’Esercito poggiato su un lato – e mi grida in faccia «men, men».
Mi avvicino, cerco di aprire subito il portellone ma è bollente, con l’aiuto di un collega ci riesco, entro e vedo quattro uomini a terra, grido subito all’esterno – quattro, sono quattro – ma solo dopo poco mi accorgo di un quinto corpo, coperto dagli altri.
La scoperta non è delle migliori, quello sotto tutti è Pietro Petrucci, un mio pari corso, un ragazzino come me, con i miei stessi ideali, la stessa voglia di riscatto e rivincita, la stessa fame. Quel corpo inerme era per me la sconfitta; Pietro morirà qualche giorno dopo ed io rimpiangerò sempre il fatto di non esser stato in grado di avergli potuto dare un’altra possibilità, ho pregato, ho chiesto al Signore di risparmiarlo, ma non sono stato ascoltato.
Come lui ne moriranno tanti altri, padri di famiglia, militari specializzati che erano alla loro ultima missione, Carabinieri prossimi alla pensione, ragazzi alla loro prima esperienza e figli di Generali, uomini di cultura e istituzioni, accomunati tutti quella maledetta mattina da un terribile destino: è che erano lì per un solo ed unico obiettivo la pace in una terra martoriata.

Oggi nelle scuole, forse questa data non verrà ricordata, non ci saranno minuti di silenzio, campane suonate in ricordo, forse qualche piccola e sparuta manifestazione comunale in qualche piccolo comune, al massimo qualche spennata corona in ricordo su quella strada o quella rotatoria che ricorda i fatti. Diciamo che quel sacrificio non troverà spazio nazionale come merita, non ci saranno catene di commemorazioni, non ci saranno lezioni di legalità o istituzionali nei licei o se succederà sarà fatto nel silenzio e non con tutti gli onori del caso. Neanche lo Stato ha fatto il suo dovere in passato e non lo si può aspettare dal mondo civile tutto sommato, basti pensare che, fino a prova contraria, le medaglie d’oro al valor militare non sono mai state consegnate, onorificenze (ben 155) date a chi non le meritava (elargite per fatti accaduti dopo la strage) eppure ricordo bene la commozione dei tanti politici e militati, corsi a prendersi un pezzo di risonanza mediatica in quei frangenti, tutti che promettevano, proprio tutti, ma poi ancora oggi, diciott’anni dopo, il nulla assoluto.

Questo è il mio più grande rammarico. Ma chi ha donato la vita in quel frangente – ed io posso ancora testimoniarne il sacrifico – non ha tutto sommato bisogno di pompe magne o di grandi riconoscimenti. Ricordo sempre il germoglio di bene che Margherita Caruso moglie del Brigadiere Coletta ha seminato con l’associazione dedicata al marito, costruendo in Africa pozzi su pozzi per dare da bere agli assetati. Già questo meriterebbe l’onore delle cronache per far intendere che nonostante tutto Nassirya da luogo di tenebre alla fine si è trasformato in luogo di pace e si sa, il bene vince sempre”.