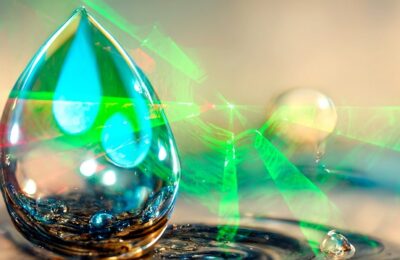Non finisce mai di sorprendere Fabrice Hadjadj, il filosofo franco-algerino che ha conquistato tutti giovedì sera a Verona nonostante il tema da trattare (“Perché dare la vita a un mortale? Essere genitori alla fine del mondo”) fosse tutt’altro che leggero. Hadjadj ha accolto l’invito di alcune scuole veronesi (Gavia, Braida e ABiCi) e nella sede della Cattolica Assicurazioni ha sfoggiato, oltre alla ormai arcinota profondità di pensiero, anche uno spassosissimo senso dell’umorismo (tanto da prestarsi simpaticamente anche a un selfie finale assieme ai suoi più accessi ammiratori, tra i quali si include chi scrive).
Perché allora dare la vita a un essere mortale? Hadjadj ha cominciato rammentando la profonda solidarietà intercorrente tra i due supremi avvenimenti dell’esistenza umana: la nascita e la morte, i due momenti estremi del nostro soggiorno terrestre uniti fin dall’inizio nello stesso interrogativo. Tale lettura ce la offre senza sosta il cimitero: in un luogo preciso, un nome proprio, la data di nascita e la data di morte.
Tutto indica che la morte ricopre di assurdità la nascita. Ma Hadjadj, citando Samuel Beckett, ci ricorda che il sentimento dell’assurdo non è primario. Se sperimentiamo l’assurdità di qualcosa come non senso, e soprattutto come sradicamento, è perché prima di tutto siamo destinati al senso. Speriamo in un senso, che lo vogliamo o meno. La morte di coloro che amiamo è per noi è così atroce perché prima abbiamo intravisto la bontà della loro vita. Se così non fosse non ci sarebbero né assurdità né interrogativo. “Solo lo stupore apre lo spazio alla tragedia”, afferma Hadjadj. La tragedia non deve farci dimenticare lo stupore originario. Uno stupore senza dubbio tradito, ferito, ma senza il quale non potremmo gridare contro il cielo.
Hadjadj ricorda a questo proposito un testo del 1985 intitolato “In vitro veritas”, uno scritto nel quale lo scrittore Philippe Muray si poneva una serie di domande fisiche e al contempo molto metafisiche: perché l’essere umano deve riprodursi in un tempo in cui al genere umano è stata offerta la possibilità tecnica di non riprodursi? come si giustifica adesso la nuda volontà di riprodursi? Per Muray questa è la domanda delle domande, un interrogativo sospeso attraverso il tempo: l’essenza stessa del perché.
Sono parole di una stupefacente profondità. Attraverso la domanda centrale – perché generare? – Muray presenta tre affermazioni al tempo stesso sorprendenti e evidenti. Prima di tutto Muray afferma che siamo dinanzi alla domanda delle domande, la quale contiene anche l’essenza del perché. La domanda fondamentale non è perché la vita valga la pena di essere vissuta e neppure quale sia il senso della vita. Domande importanti, ma che non hanno la stessa necessità né la stessa urgenza. Sono le domande dei filosofi, i quali del resto – osserva con ironia Hadjadj, padre di sei figli – hanno una spiccata tendenza a non procreare.
La questione della fecondità umana si perde nella notte dei tempi. Miti e riti se ne sono occupati. Rémi Brague osserva che una volta che si è in vita non c’è affatto bisogno di grandi ragioni per restarvi. Per restare vivi basta una certa inerzia, un certo lasciarsi trascinare dal corso del tempo. Viceversa, abbiamo assolutamente bisogno di ragioni per dare la vita. E gli interrogativi filosofici difficilmente ci farebbero alzare al mattino dal letto per iniziare la giornata. Ma d’altro canto è da dubitare pure che la marmellata di fragole e le notizie fresche del mattino possano darci sufficienti ragioni per figliare…
Senza contare che, a differenza degli animali, l’uomo non è soggetto alla necessità dell’istinto. In particolare l’italiano medio pare comportarsi in maniera decisamente diversa rispetto al cervo che si accoppia alla cerva solo nel periodo dell’estro. L’uomo non va in calore, ha invece un fervore rituale. Nella specie umana lo slancio naturale, per giungere al suo scopo, deve essere riaffermato in modo culturale. Per natura l’uomo è un animale razionale. Pertanto la sua tendenza naturale a dare la vita non si avvera spontaneamente, in maniera irriflessa, dovendo passare attraverso una ragione più o meno esplicita.
Seconda affermazione: la domanda sulla fecondità fino ad oggi è rimasta sospesa nel tempo. Forse che la questione della fecondità non ha mai trovato risposta? Sì, ne ha trovate molte nel corso dei secoli. Non è mai stata infatti la quantità di risposte a fare difetto. Era la domanda stessa a mancare. Un tempo fare figli non era un interrogativo quanto uno scopo indiscutibile. La fecondità era quasi un imperativo categorico, giacché la fertilità assicurava il mantenimento e la prosecuzione della stirpe. La filiazione pertanto era una necessità, non una domanda o un problema. Così però ci siamo infilati in un vicolo cieco: da quando mettere al mondo dei figli è diventato un atto problematico ci siamo trovati sguarniti pur avendo a disposizione un arsenale di risposte. Questo perché in realtà erano risposte a una non-domanda, o piuttosto a un interrogativo che non si poneva davvero come tale. Figliare era un atto scontato, necessario, un dovere sociale.
Sempre, in ogni società tradizionale, miti e religioni si sono occupati della fecondità. La religione tradizionale infatti non fa altro che garantire la successione delle generazioni. Il fulcro del rito è la genealogia; nei suoi riti più fondamentali la religione si occupa, prima che della morte, della fertilità.
Con la filosofia si consuma una prima frattura: la logica tende a separarsi dalla genea-logica. La domanda sull’origine diventa la ricerca di una causa universale, non quella di una famiglia particolare. Il filosofo si chiede perché c’è qualcosa invece che il nulla, ma tende a dimenticare che la sua stessa domanda è resa possibile dal fatto di essere nato e di aver ereditato una lingua dai propri genitori. La filosofia tende a interrogarsi su un uomo astratto, su un uomo con la U maiuscola, cosa che rischia di far dimenticare ancora una volta la concretezza di un fatto originario: che gli uomini sono anche padri, madri, mariti, mogli, figli e figlie, fratelli e sorelle.
Col filosofo si opera la separazione complessiva del saggio dal padre, del pensatore dallo sposo. I filosofi concordano che è meglio non sposarsi e non avere figli. E anche quando non ne parlano spesso e volentieri rimangono celibi, tanto che si può sospettare che questionare sulla felicità, tipica attività filosofica, abbia arrecato non pochi danni alla fecondità. La ricerca di una vita tranquilla e serena, centrata sull’autorealizzazione, pare infatti conciliarsi poco con le tribolazioni della paternità (incluse quelle, certo non secondarie, coi parenti acquisiti). Questa separazione tra pensiero e fecondità spiega forse, osserva Hadjadj, lo scarsa presenza di donne-filosofo in epoca classica. Certo non perché le donne fossero meno intelligenti degli uomini, tutt’altro. Ma forse questa disincarnata separazione tra realizzazione e procreazione non era affatto così evidente a occhi femminili.
In tempi molto recenti a svilire la fecondità è stata anche la concezione strumentale della maternità diffusa dall’ideologia del natalismo politico. È noto che la popolazione europea nell’Ottocento si è più che raddoppiata. Grazie ai progressi medici, indubbiamente, Ma in questa proliferazione c’entra anche, e molto, l’utopia del progresso. Occorreva infatti fare figli per assicurare il trionfo alle “magnifiche sorti e progressive” della Patria, del Partito, del Reich o del Soviet (e oggi allo Stato islamico: il parto come jihad delle donne). Il partorire così non era più un fine in sé, essendo stato degradato a mezzo.
Così assistiamo a un folle paradosso: basta che fare figli non sia più considerato un mezzo adeguato che tutto si capovolge. Nella Cina di Mao ad esempio le donne con più di dieci figli erano premiate come “madri d’onore”. Ma con la politica del figlio unico inaugurata da Deng Xiaoping nel 1979 quelle stesse madri sono state invece considerate nemiche del popolo. In Occidente non vale diversamente: le madri prolifiche appaiono come nemiche dell’ambiente naturale…
Che sia stato ad opera del mito, della filosofia o dell’utopia ideologica, è un fatto che la domanda sulla fecondità è rimasta sospesa. E oggi ci cade addosso con violenza inaudita, come se fosse il cielo stesso a caderci addosso.
Oggi, ed è il terzo punto, la risposta alla domanda si aggrappa a una volontà tutta nuda, senza puntelli sociali. Almeno in Occidente la società non si fa più carico del perché fare figli. La volontà di mettere al mondo esseri umani è sempre più una decisione individuale, quasi una scelta privata. Eppure è una cosa piuttosto contraddittoria, perché lasciare un’eredità dopo di sé è attività sociale per eccellenza, certo non riducibile a un hobby o a una qualche specie di gusto privato.
Con la privatizzazione della filiazione si consuma una autentica rivoluzione della fecondità, dietro alla quale c’è certamente la contraccezione (condom, pillola, aborto). Ma c’è anche la tecnologizzazione integrale dell’esistenza: il parto indolore, la fecondazione in vitro, la procreazione artificiale, l’esproprio della funzione procreativa da parte della bioingegneria… Questi progressi tecnologici si accompagnano poi a una ideologia di difficile interpretazione. È la causa o l’effetto delle tecnologie riproduttive? Difficile dare una risposta. Resta comunque un’evidenza: secondo questa ideologia il dono della vita si trasforma in diritto. Un inalienabile diritto al figlio, anzitutto. Ma è un diritto ancora una volta venato di ambiguità perché legato al diritto di non avere figli e di sopprimerli. Nasce la figura inedita del “figlio del desiderio” (M. Gauchet): il figlio scelto, programmato voluto. Ma il “figlio del desiderio” è al tempo stesso anche un potenziale “figlio del rifiuto”, un figlio-scarto rottamabile se non rispetta il programma del genitore-designer.
Così la nascita per via sessuale, caratterizzata dal contingente e dall’imprevisto, cede il passo alla fabbricazione pianificata del nascituro per mezzo dell’ingegneria biogenetica. “Non si tratta più di trasmettere la vita ricevuta ma di produrre un essere adattato ai nostri progetti, la cui esistenza sarà funzionale, i giorni piacevoli, la morte dolce”.
Inoltre questi avanzamenti si iscrivono in un contesto segnato da una duplice crisi. Anzitutto una crisi ecologica, nella quale le risorse naturali appaiono in corso di esaurimento. Una crisi che sembra richiedere non solo una compressione dei consumi ma anche la contrazione delle nascite: consumare meno, generare meno per preservare la foreste devastate dall’industrialismo selvaggio.
Dall’altra parte c’è la crisi antropologica: le armi atomiche (in questo senso davvero “apocalittiche”) hanno manifestato la mortalità della specie umana nel suo insieme, non più soltanto dei suoi componenti. La minaccia del nucleare rende tragicamente attuale l’ipotesi di una scomparsa dell’intera specie umana, ben al di là della fine dei singoli individui. “Non si dirà mai abbastanza quanto la presa di coscienza che le specie sono finite, e non solo gli individui, sia uno sconvolgimento del pensiero antico”, dice Hadjadj. Per gli Antichi, in particolare per Platone e Aristotele, la specie è una realtà perpetua. E questa perpetuazione della specie è il modo con cui gli esseri umani partecipano al divino, di modo che “la mortalità sul piano individuale è compensata da un’immortalità sul piano della specie”. Così il dono della vita particolare veniva giustificato dalla perennità del bene comune. La domanda è: se questa perennità è messa radicalmente in discussione, se la procreazione appare destinata alla scomparsa totale, a che serve continuare?
Siamo in una situazione senza precedenti, dove ogni valore del passato sembra invertito. Fino a ieri era la società a fornire ai suoi membri ragioni per vivere e per dare la vita. Ora la politica per contro appare impegnata a costruire una società – o meglio un dispositivo sociale – “che attraverso il consumo fornisca innanzitutto ragioni di divertirsi davanti all’angoscia della morte e di legittimare il suicidio come divertimento finale”. Un tempo la generazione permetteva l’accesso a uno status sociale sempre più importante, per cui al culmine della scala sociale lo status supremo era quello di “antenato”. La dignità di Abramo sta nell’essere padre di una moltitudine di popoli, Dio stesso genera nel suo seno il Figlio e attraverso di lui genera il suo Spirito. “Nel dispositivo attuale”, invece, “l’antenato è quello a cui occorre fornire l’eutanasia. Essere padre o madre non fornisce alcuno status sociale. Al contrario, è segno di un’inferiorità, di una degradazione, di un impedimento al raggiungimento dello status magnificato di soggetto autonomo, o piuttosto di “lavoratore atletico”, sempre giovane, sempre disponibile all’incontro furtivo, allo straordinario, alle ultime innovazioni della tecnica”. È in obbedienza a questo nuovo ideale sociale che in Germania dell’Est, subito dopo la riunificazione, centinaia di donne si sono fatte sterilizzare, pensando così di mostrare ai nuovi datori di lavoro la propria “libertà”, la libertà di essere “consumatrici stabili e consumatrici molto serie”. Una libertà a dir poco equivoca, coincidente con quella che Ernst Jünger avrebbe chiamato “mobilitazione totale”. E come dimenticare che nell’universo concentrazionario e ipertecnologico del “Mondo Nuovo” di Huxley campeggia questo motto: “la civiltà è la sterilizzazione”?
Un altro segno dei tempi è la domanda della filosofa canadese Christine Overall: è etico fare figli? Secondo Overall l’onere della prova si è ormai invertito: non è più che non vuole avere figli a doversi giustificare, bensì chi vuole averne. Ieri la generazione appariva come una specie di legge sociobiologica che richiedeva conformità e sottomissione. Oggi la generazione è una scelta, il risultato di una deliberazione lucida e razionale. Alla luce di questa situazione, scegliere di non avere figli è una strada etica meno rischiosa, meno impegnativa. Giacché esseri inesistenti non possono soffrire, il dovere morale di preservare i potenziali nuovi venuti dalla vulnerabilità (ovvero dalla sofferenza) impone di non farli venire al mondo. Se invece il bambino viene al mondo, abbiamo una responsabilità serissima nei suoi confronti: difenderlo ad ogni prezzo da ogni rischio, da ogni dolore, da ogni sofferenza. In questo modo, per assurdo, il bene del bambino va contro la sua stessa esistenza. Se non può godere di condizioni di vita eccezionalmente favorevoli, il cucciolo d’uomo non deve venire al mondo. Ieri non poteva perché la medicina non aveva fatto abbastanza progressi, oggi non deve perché la medicina ha fatto troppi progressi.
Così in sostanza argomenta Christine Overall, che concede la patente di “eticità” alla procreazione solo a patto che questa rispetti una serie di condizioni stringenti (benessere dalla madre e del bambino, autonomia delle donne, rifiuto di considerare madre e bambino altro che fini in se stessi).
Il problema è che c’è una buona probabilità che il rispetto di simili parametri richieda un tempo di riflessione molto lungo. Diciamo ben al di là dell’età della menopausa, quando la saggezza permetterà di soppesare i pro e i contro… La realtà è che lo spirito matematico e l’eccessiva prudenza mal si conciliano con lo slancio giovanile dell’amore, col coraggio, con quell’abbandono di sé al rischio senza pensare troppo al proprio benessere. In breve, con quelle che sono le condizioni indispensabili di ogni impresa creativa, prima fra tutte quella di generare nuove vite. Per questo le madri del passato, che figliavano senza pensarci troppo, appaiono oggi come mamme coraggio oppure c0me schiave sottomesse. Non solo la vita futura è guardata con sospetto e terrore, ma anche la vita passata. E così, “tentando di legittimare con un calcolo etico-razionale la vita che potremmo dare, noi delegittimiamo la vita che abbiamo ricevuto, che di un tale calcolo se ne infischiava”.
Siamo di fronte a un estremo paradosso: è quando si scopre la dignità unica del figlio, è nel momento in cui diventa un fine in sé, e non più il mezzo per propagare la tribù o la specie, che dargli la vita diventa un dilemma straziante: “perché dargli questa vita che va verso la morte? perché consegnarlo a un mondo che finirà per stritolarlo?”.
Un altro nodo si aggiunge al groviglio prodotto dallo spirito organizzativo: il modello contrattualista. Secondo le moderne teoria della società il mondo è una rete di relazioni simmetriche, il prodotto di un contratto sociale tra individui eguali. Ma l’origine e la nascita non sono asimmetriche né egualitarie: nessuno di noi ha origine in se stesso né potrà ma diventare padre o madre di se stesso. E la nascita non è pensabile come un contratto: possiamo mai chiedere a un figlio se acconsente o meno a venire al mondo? Come può un figlio scegliere di nascere? La conclusione è sconfortante: sembra proprio che “più la dignità della vita è ricondotta a una scelta individuale, più diminuisce la possibilità che ci siano viventi”.
Non sembrano essere rimaste che due alternative altrettanto estreme, osserva Hadjadj: da una parte non si tratta più soltanto di “trovare ragioni per dare la vita a un mortale”, ma, nel catastrofismo attuale, “di essere genitori nella prospettiva della fine del mondo”; dall’altra è sospetta anche la sola idea di cercare una ragione, di trovare un perché al fatto di voler mettere qualcuno al mondo.
Ebbene, quando è il “perché” stesso a essere in questione, quando ci chiediamo il perché del perché siamo su un crinale. Ci troviamo “al limite dell’assurdo e della grazia”. Come si esce da questo vicolo cieco? Hadjadj risponde da cristiano: più il tempo si fa apocalittico, più dare la vita a un mortale si aggrappa alla speranza teologale, la paolina “spes contra spem”. La fine di questo mondo per un cristiano non è la fine di tutto. Per chi crede in Cristo ha senso accogliere la vita e partorirla anche nei pochi istanti precedenti la fine dell’universo, giacché “la fede nella vita eterna apre una strada nel mare della morte” ricordandoci che “non generiamo per questo mondo che passa ma per compiere il numero degli eletti al cielo”.
Arrestarsi a queste considerazioni però non sarebbe altro che ripetere una lezione di catechismo un po’ meccanica. La rivelazione tuttavia non ci dà un sistema di risposte a tutto così da esentarci dalla riflessione (la qual cosa ne farebbe solo un “fattore di imbecillità”). Piuttosto sollecita la nostra intelligenza a una meditazione sempre più profonda delle realtà rivelate. In questo caso ci invita ad approfondire il legame intimo tra la vita mortale e la vita terrena, “tra il semplice fatto di generare quaggiù e la generazione eterna del Figlio unico del Padre nello Spirito”. E non solo: ci viene così mostrato che “il sesso è legato essenzialmente allo spirito, che il rapporto sessuale mette in gioco la relazione divina, che la speranza teologale è necessaria non solamente nelle nostre teste ma anche, prima di tutto, nelle nostre mutande”.
Come comprendere questo intreccio tra ciò che c’è di più soprannaturale e ciò che è più naturale? Come capire che in certo qual modo “le nostre parole più quotidiane sono già implicitamente parole di Vangelo” e che bisognerà sempre più rivolgersi al Vangelo per dire davvero “buongiorno” (come ci ha abituati il linguaggio di papa Francesco), cioè per credere veramente nella bontà del giorno?
Bisogna guardare ancora alla luce della divina speranza, ci suggerisce Hadjadj: “È quando la notte sembra trionfare che un chiarore piccolissimo appare come ambasciatore di tutta la luce. Allora ci si rende conto che il semplice fatto di dare la vita contiene già un’oscura fiducia nella vita eterna, che non è una fiducia che sta sul piano psicologico ma una fiducia consustanziale alla vita stessa, quella vita che procede dal vivente e torna al vivente. Perché è evidente che il nostro sesso ci spinge naturalmente verso l’altro sesso e che naturalmente questa unione si apre sulla procreazione come l’incontro della chiave e della serratura apre la porta di una casa sconosciuta”.
Allo stesso tempo questa attività così spontanea e scontata nell’animale, nell’uomo non può che essere giustificata attraverso una meditazione più alta, metafisica. Nell’uomo il nome viene prima del numero, la fruttificazione prima della proliferazione. Ciò riporta alla domande sul “perché” della fecondità. È vero che nell’uomo, a differenza dell’animale, la generazione passa non per l’istinto ma attraverso intelligenza e libertà. Ma è anche vero che a troppo cercare il “perché” e il “percome” della procreazione ci si dirige verso l’estinzione. “La ragione umana ha bisogno dell’animalità per entrare in una razionalità viva”. La ragione umana, senza il suo ancoraggio fisco e carnale nel sensibile, perde il contatto con la realtà e dunque con la vita. Il mondo del pensiero slegato dal mondo fisico diventa aberrante, gira a vuoto: “la logica diventa aberrante appena si separa dal mondo fisico, appena non è più genea-logica”. Una ragione disincarnata – e perciò asessuata – disprezza la nascita e non è più motivata per la vita.
È allora che la ragione sragiona cercando con insistenza maniacale una ragione al perché. Ma la “causa prima”, ci ricorda il filosofo nato a Nanterre, “è necessariamente senza causa, il perché estremo è senza perché e richiede, al di là del ragionamento logico, una risonanza viva”.
La verità è che la vulnerabilità caratterizza l’essere umano in quanto tale, sicché dare la vita è anche dare la morte (nel senso di mettere al mondo un essere mortale). Solo sulla Croce di Cristo la morte diventa offerta della vita, generosità suprema.
L’eccesso di calcolo, l’ossessione del perché si rivelano in tutta la loro falsità perché considerano la nascita come un progetto e non come un avvenimento. Un fatto che avviene ci mette in contatto con l’imprevedibile, per cui sono i nostri progetti a doversi adeguare a quella realtà, non il contrario. La nascita è precisamente un avvenimento che sconvolge la vita dell’uomo. E questo è vero, ma è anche ciò permette una rinascita, un rinnovamento. La nascita non può essere un progetto, sono i miei progetti a doversi adattare alla nascita. La nascita di un figlio è un rinnovamento del nostro essere, è l’avvenimento che trasforma l’individuo in padre. Una trasformazione impossibile da prevedere in anticipo. Per questo la responsabilità segue la procreazione, ma non la precede. Si diventa responsabili quando si diventa padre o madre.
Essere genitori, in definitiva, è farsi simili all’amore. E “per amore”, conclude Hadjadj, “significa “senza perché”, senza altra ragione estranea all’amore stesso. Per chi è fuori sembra un’assurdità. Per chi è dentro appare come una grazia”.
ARTICOLO TRATTO DALLA VERSIONE PER ABBONATI, SOSTIENI LA CROCE ABBONANDOTI QUI www.lacrocequotidiano.it/abbonarsi-ora