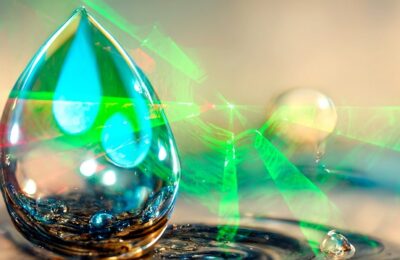Arte – Mostra dedicata a Eugen Dragutescu presso l’Accademia di Romania in Roma
Grande evento in corso presso l’Accademia di Romania, Sala Esposizioni (Viale delle Belle Arti, 110) a Roma dove si sta celebrando un appuntamento molto interessante per chi ama l’arte e vuole scoprire un grande artista della cultura rumena. Si tratta dell’inaugurazione di una mostra dedicata a Eugen Dragutescu presso l’Accademia di Romania in Roma – dove l’artista ha soggiornato in quanto borsista – è un atto necessario affinché la sua ampia opera grafica sia ricordata al pubblico italiano. Nato in Romania, egli si è stabilito in Italia, dove ha vissuto dal 1946 e fino alla fine della sua vita nel 1993. È stato un artista che ha goduto di un’ampia reputazione nel mondo artistico italiano.
I suoi disegni raffiguranti città italiane, vari personaggi della vita culturale o gente comune sono stati esposti nell’ambito di numerose mostre in Italia, Olanda, Messico, Stati Uniti d’America e Romania. A Roma e ad Assisi Eugen Dragutescu era una presenza costante tra artisti, scrittori e musicisti che ha immortalato in ritratti pieni di sensibilità. I ritratti del suo amico, il poeta Giuseppe Ungaretti, realizzati lungo tre decenni, sono stati esposti in una mostra del 1970.
La mostra di Eugen Dragutescu comprende una selezione di circa 60 opere tra disegni a inchiostro, acquarelli, matite colorate e alcuni dipinti a olio appartenenti al patrimonio di musei della Romania e del Gabinetto Stampe della Biblioteca dell’Accademia Romena di Bucarest.
La selezione delle opere desidera mettere in rilievo l’influenza del disegno italiano – in particolar modo di quello barocco – studiato durante il periodo di residenza a Roma in quanto borsista dell’Accademia di Romania. Salvator Rossa, Aureliano Milani, Donato Creti, Francesco Zucarelli sono i veri maestri di Dragutescu. Già padrone lui stesso di tale arte, Dragutescu ha saputo adattare una maniera “attempata” all’arte contemporanea, ha saputo ridefinirla e renderla attuale. Questo primo periodo di creazione rappresenterà il suo biglietto da visita a livello artistico, la somma degli elementi stilistici che definiranno la sua grafica inconfondibile.
La sua opera è composta da due grandi cicli: disegno libero e illustrazione di libri.
Alla prima categoria appartengono i disegni che formano una sorta di diario che con le sue annotazioni giornaliere ricostruisce il suo modo di vivere come sensibile osservatore dello spettacolo del mondo circostante. La seconda categoria, riferita all’illustrazione di libri, è una provocazione per l’artista che trasforma il testo in immagine. Per il lettore l’illustrazione diventa l’immagine che accompagnerà la parola e si sostituirà ad essa, conservando le sue qualità letterarie e amplificando i suoi sensi.
I disegni possono essere raggruppati in alcune grandi serie che si sono succedute con il passare degli anni. Durante i concerti ai quali assiste e durante i quali abbozza la figura del direttore d’orchestra (Alfredo Casella, Franco Ferrara, Constantin Silvestri, Sergiu Celibidache, George Enescu) l’artista soprende il movimento scomposto in innumerevoli gesti e contorsioni del corpo che ricordano il futurismo. A differenza dei futuristi, però, interessati solo della scomposizione del movimento in quadri successivi, Dragutescu combina tale movimento con la musica come sull’immaginario spartito di una danza.
Ad Assisi inizia una serie di disegni riuniti in un album dall’editrice Vallecchi di Firenze. I disegni formano un’immagine completa della città con le sue strade e i suoi monumenti recanti l’impronta di S. Francesco, con i ritratti di abitanti e in particolar modo dei monaci sopresi in scene di vita monacale. I paesaggi sono per l’artista un momento di sincerità in cui, libero da ogni costrizione, esprime il suo “stato d’animo”. Il ritratto rimane, però, la sua occupazione più importante. Disegnerà ritratti di personalità di spicco come Giuseppe Ungaretti, (i ritratti di Ungaretti realizzati lungo tre decenni sono stati esposti in una mostra del 1970), Giovanni Papini, Eugenio Montale, Giorgio de Chirico, Dino Buzatti, Constantin Brancusi, Ana Blandiana, ma anche ritratti di amici e di bambini. In tutti si ritrova il desiderio di appropriarsi di quel tratto di carattere che li rende unici e in tal modo – consegnandoli alla carta – fissarli per sempre.
L’illustrazione di libri è un’immagine pensata. Dall’opera di Shakespeare, ai racconti di Andersen, al romanzo e alla poesia, Dragutescu disegna ritmo e metafore. Il bisogno di espressione visiva lo determina a realizzare dopo la serie di disegni dedicati al poeta Ion. A Bucur anche un film con la durata di alcuni minuti: „Moartea tânarului poet/La morte del giovane poeta” vince il I premio al Festival Internazionale di Cortometraggi a Cork (Irlanda).
I disegni di Dragutescu non sono schizzi realizzati in vista di un futuro quadro; sono opere definitive sgorgate da un’inesauribile bisogno di rendere in immagini la propria vita. Teatralità, drammatismo, dinamica, oppure gioia, musicalità, innocenza sono espressi tramite un disegno fatto da minuscole linee che in innumerevoli forme e direzioni sintetizzano l’argomento. Percorrere le centinaia e le migliaia di disegni è un’impresa accattivante e mai noiosa grazie proprio alla diversità di argomenti e di stili grafici di colui che è stato definito da Aldo Ferabino ”il poeta-pittore o il pittore-poeta”. Eugen Dragutescu definisce se stesso in quanto artista tramite la capacità di adattamento stilistico al soggetto, tramite la diversificazione della sua maniera di disegnare che è unica e personale. Costante della sua arte è la facilità con la quale attraverso poche linee riesce a trasmettere l’espressività di un gesto, di un movimento, di una smorfia come in un’istantanea sintetica ma non fotografica. La linea, tratteggiata ad inchiostro con una stilografica speciale con duplice serbatoio, segue il contorno della figura dopodichè si spezza e ondeggia in piccole volute oppure si ispessisce in tratteggi pieni. Un pastello o un acquerello disposti casualmente riescono a mettere in rilievo un tratto caratteristico del modello.
La mostra che omaggia Eugen Dragutescu è un frammento dell’esistenza di un artista che ha offerto agli spettatori l’immagine di un mondo nei suoi dati essenziali. Coloro che ammirano i suoi disegni entrano in un universo senza tempo e diventano testimoni della ricreazione delle meraviglie del mondo grazie ad un semplice e sinuoso tratteggio con la penna ad inchiostro.
Tutto questo nello splendido scenario dell’Accademia di Romania di cui non tutti conoscono la storia.
Nel 1920 il Parlamento della Romania approvava una legge – ideata e promossa dallo storico Nicolae Iorga (1871-1940) e dall’archeologo Vasile Pârvan (1882-1927) – che prevedeva la fondazione di accademie romene all’estero: la Scuola romena di Fontenay aux Roses a Parigi e la Scuola Romena di Roma. Erano entrambe destinate al perfezionamento dei giovani romeni nel campo delle discipline umanistiche (lettere classiche e moderne, storia ed archeologia), delle belle arti e dell’architettura.
L’8 luglio 1921 il Governatore di Roma metteva a disposizione dello Stato romeno un terreno a Valle Giulia per la costruzione di un immobile che accogliesse un’Accademia di Storia, Archeologia e Belle Arti. La Scuola iniziò l’attività il 1° novembre 1922 in una sede provvisoria in Via Emilio de’ Cavalieri 11. L’attuale sede, inaugurata nel gennaio 1933, fu edificata sotto la direzione dell’architetto Petre Antonescu, grazie alla munificenza della Banca Nazionale della Romania, che sostenne tutte le spese di costruzione. A quella data funzionava già la British School in un vicino palazzo e, nei decenni seguenti, con l’edificazione delle altre accademie straniere, Valle Giulia si trasformò un una vera e propria “Valle delle Accademie”.
Dal 1922 al 1947 alla Scuola Romena furono inviati dalle quattro università della Romania d’allora (Bucarest, Cluj, Iasi e, fino al 1940, Cernauti) i migliori laureati nelle discipline: archeologia, storia, lettere, belle arti ed architettura. Le borse di studio erano elargite dal Ministero romeno dell’Istruzione pubblica. L’attività scientifica della Scuola era patrocinata dall’Accademia Romena di Bucarest. Circa 170 giovani romeni poterno perfezionarsi alla Scuola Romena/Accademia di Romania di Roma, diventando di seguito personalità di rilievo in Romania e all’estero.
Fondatore della Scuola e primo suo direttore fu Vasile Pârvan (1922-1927), a cui si succedettero nella direzione G.G. Mateescu (1927-1929), Emil Panaitescu (1929-1940), Dumitru Gazdaru (1940-1941) e Scarlat Lambrino (1941-1947). Nel 1923 uscì il primo volume dell’annuario della Scuola (Ephemeris Dacoromana), che riuniva lavori di storia, archeologia, storia dell’arte ed architettura, lettere classiche e moderne, storia della letteratura, firmati dai membri della Scuola. Fino al 1945 furono pubblicati dieci numeri dell’annuario. Dal 1925 fu inaugurata una seconda pubblicazione – Diplomatarium Italicum, che presentava raccolte di documenti sulla storia e la cultura romena raccolti nelle biblioteche e negli archivi italiani (ne furono pubblicati fino al 1939 quattro volumi). Periodicamente erano organizzate all’Accademia mostre d’arte ed architettura dei suoi membri. La Biblioteca della Scuola raggiunse fino all’inizio della seconda guerra mondiale circa 13.000 volumi. Alle conferenze dell’Accademia di Romania intervennero Th. Ashby, Chr. Huelsen, Jérôme Carcopino, Émile Mâle, Giulio Quirino Giglioli, Adolfo Venturi, Cesare de Lollis, Vittorio Rossi, L. Curtius, Ettore Pais, Roberto Paribeni, R. Bianchi-Bandinelli, A. Maiuri. Nel 1945 l’Accademia di Romania divenne uno dei membri fondatori dell’ Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell’Arte di Roma.