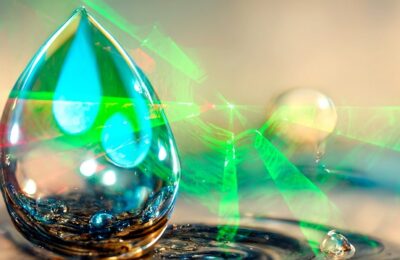Con l’avanzare imperioso dell’età anagrafica mi diviene quasi consuetudine, ogni tre parole su due, il forte intercalare dialettale, nei rari discorsi che biascico tra conoscenti o interlocutori occasionali. La “vecchiaia” si porta appresso il ritorno alla lingua primaria parlata assiduamente tra le mura domestiche nella famiglia natale, piaccia o meno. Per i miei figli è orrore allo stato puro (“talis pater, no talis filius”), per me grazia immensa e ulteriore occasione di radicamento all’amatissimo suolo locale. Esistono peraltro termini impossibili da tradurre in italiano comune dai vari idiomi locali. È questo il bello, e la peculiarità, che rende magico ogni angolo remoto del nostro inimitabile Belpaese. Impossibile, per esempio, fare una traduzione precisa del mitico bergamasco “pòta”, troppe le variabili in campo nel linguaggio comune, il risultato non sarebbe serio e accettabile. Negli strumenti di lavoro agricolo poi esistono una molteplicità di attrezzi del tutto particolari in cui la trasposizione nella lingua di Dante è assai ardua se non impossibile. Spesso sono utensili caduti in disuso, unici, come la “fraschera”. Questo arnese tipico della montagna orobica serviva al trasporto dell’erba secca nei cascinali. Si infilzava il palo in terra ben ancorato e si disponevano sul rettangolo in legno possenti bracciate di fieno amalgamate col rastrello; il tutto poi era chiuso a cerniera con la corda appositamente tesa e legata nel paletto estirpato dal suolo. Il fascio veniva capovolto all’insù, e
con un colpo di ginocchio ben assestato tra i due legni verticali si creava la nicchia per appoggiarci la testa.
L’incaricato al trasporto si posizionava davanti seduto, spalle ben ancorate alle assi e cranio nell’incavo, qualcuno sul retro dava una forte spinta, e con un secco colpo di reni ci si alzava per partire in direzione del fienile. Non sempre queste due ultime operazioni risultavano agevoli: se il fieno non era ben secco, il tragitto lungo, o il carico eccessivo per le proprie forze, si rischiava di capitolare e dover tentare da capo la risalita da terra. Il segreto per agevolare la manovra era porre la “fraschera” in un leggero declivio in modo che la gradazione di pendenza favorisse la rialzata, dimezzando la fatica.
Ho usato questo strumento lavorativo per la fienagione sino all’età di trent’anni, quando motocarriole e imballatrici lo hanno pensionato del tutto. Rastrelli e falci sui nostri pendii impervi erbosi rimangono invero utilissimi, per chi li sa usare correttamente, ma la “Signora fraschera” no, lei è scomparsa malinconicamente quasi del tutto. Certamente non rimpiango la fatica (a volte davvero immane) e i fiumi di sudore spesi sotto questo arnese, però un filo di nostalgia quando passo vicino al deposito dove giacciono impolverate le sorelle in legno (e in corda) mi viene. Possediamo in famiglia, presso la nostra baita nel paese d’origine, una “fraschera” (vedi foto in calce allo scritto) datata 1858; praticamente ha quasi due secoli di vita, ma è ancora robustissima, solo il palo è stato sostituito in quanto marcescente. Ha visto sicuramente diverse generazioni di portatori e decine di tonnellate di fieno passare sopra di lei. Ho avuto il piacere, se tale si può definire, di sentirmela appoggiare sulle spalle svariate volte lustri orsono. Con lei ho fatto un pezzo non indifferente di vita giovanile. Grazie a lei ho degli eccellenti muscoli al collo, ho
irrobustito articolazioni e spalle, rigenerato i flaccidi nervi corporei, vinto la tentazione di cedere sotto pesi non indifferenti. A nemmeno dieci anni di età già boccheggiavo sotto il peso di fieno e “fraschera”, sante persone coloro che mi hanno avviato in questa arte lavorativa in tenera età strappandomi dal bighellonare tipico della preadolescenza. Insomma, è stata un po’, col senno di poi, una scuola di vita che mi ha in parte aiutato a vincere la mollezza di un carattere e di un fisico sin troppo esili e titubanti; lo dico sempre (inascoltato) alla figliolanza: senza sacrifici non sarete mai felici, solo col sano sudore della fronte si forgia il carattere e ci si prepara alla bell’e meglio alle intemperie del vissuto. Mi sembra di rivedere un film in bianco e nero quando la pellicola della memoria mi proietta scene di uomini e donne carichi di fasci e di fatiche diretti verso baite annerite dalla fuliggine. Se la giornata prometteva bel tempo il suono iniziale di sottofondo era il canto delle “ranze” (falci in dialetto locale) la mattina presto, prima del sorgere dell’astro solare quando l’erba è ancora umida di rugiada, mentre venivano molate con la pietra. La musica pomeridiana invece risultava più flebile e quasi impercettibile: la intonavano i rastrelli all’unisono nelle loro funzioni tipiche di pettinare prato e fieno. La sera prima del riposo il componimento armonico si faceva più
forte, secco, ritmato, con la battitura delle falci sull’incudine per l’opportuno affilamento. Tutto in legno e ferro locali per scene con personaggi umili, poveri ma coriacei, per arti che vanno scomparendo lasciando spazio al vuoto di una globalizzazione fatta solo di solitudine iper-connessa. Un ultima nota per salutare a dovere la “Signora fraschera”: chissà perché tutti gli ingressi dei fienili sopra le nostre stalle erano (e sono) di una bassezza mostruosa. Quando giungevi col fiatone, e le energie agli sgoccioli, era un supplizio dover entrare per quelle porte strette e basse; occorreva un ulteriore sforzo suppletivo in grado di disintegrare la schiena. Vedo in ciò, senza retorica, un tipico passaggio evangelico caduto in disuso, proclamato solo a parole ma mai nei fatti nella realtà quotidiana.
La scena finale che voglio narrare è una storia vera, da pelle d’oca al solo pensiero, capitata nel secolo scorso al papà della mia grande amica Maria Letizia. Questi era giunto, col fascio in spalla e testa, nel casolare dove accudiva le bestie da latte proveniente da un prato impervio non lontano dalla sua dimora e si stava accingendo a spanderlo uniformemente nel fienile. Un attimo di respiro per prendere fiato prima di quest’ultima operazione quando si accorse con uno sguardo furtivo che nella nicchia sopra la testa, orrore allo stato puro, vi era attorcigliato un velenosissimo aspide. In pratica il rettile aveva fatto tutta la strada sopra la sua calotta cranica senza inoculare il veleno, incredibile. Caso? Fortuna? Grazia ricevuta? Io ci vedo, ma è opinione personale assolutamente confutabile, un altro paradigma di stampo messianico utilissimo per tutti, lo scrivente in pole position. Di fronte alla fatica degli umili persino la vipera ha rispetto e non ti morde. Come a dire: se resisti, fai il bene, e stringi i denti, il male non ha la forza per distruggerti, perché tu sei diventato più forte.