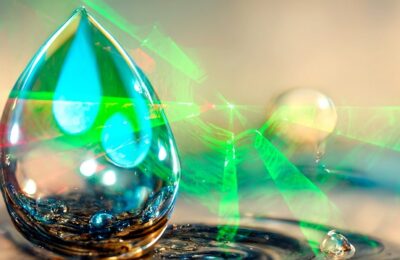LIBANO – I libanesi ricordano il terzo anniversario della tragedia che il 4 agosto 2020 ha sconvolto (e ferito) una parte consistente della capitale. L’inchiesta al palo a causa delle resistenze interne e al conflitto interno fra poteri.
Per il cardiologo Nazih el-Adm, l’esplosione di una montagna di sacchi di nitrato di ammonio, il 4 agosto 2020, è equiparabile a un “crimine di Stato”. L’enorme esplosione è stata innescata da un precedente incendio in un magazzino dell’area portuale della capitale libanese, all’interno del quale venivano stoccate senza alcuna precauzione tonnellate del composto chimico (usato come fertilizzante) e ferme a Beirut dalla fine del 2013.
Tra le 230 vittime di questa tragedia, considerata una delle più potenti esplosioni non nucleari dei tempi moderni, vi era anche sua figlia, Christelle. Questo ”crimine di Stato”, come afferma il medico, nasconde altri tre crimini. Il crimine di silenzio, dal momento che il nitrato di ammonio è stato introdotto in Libano alla fine del 2013, cioè sei anni prima della tragedia; un crimine di fatto; infine, il crimine dell’occultamento, dal momento che “si sta facendo di tutto per evitare che l’opinione pubblica sappia chi ha introdotto il nitrato, per quale motivo e chi, per negligenza criminale, ha chiuso un occhio sulla sua presenza”.
E se è pur vero che sono stati effettuati una ventina di arresti nell’ambito dell’indagine avviata dopo l’esplosione, va anche precisato che i due titolari dell’inchiesta che si sono succeduti alla guida della Corte di giustizia, chiamata a esaminare il caso, ovvero Fadi Sawan e Tarek Bitar, hanno entrambi incontrato sempre più ostacoli. Insieme al dottor Nazih el-Adm, decine di familiari delle vittime trovano “logico” che i veri responsabili della tragedia siano proprio coloro che impediscono l’avanzamento delle indagini. In questi tre anni diversi gruppi che difendono i diritti dei parenti delle vittime – il più grande dei quali è guidato dall’Ordine degli Avvocati di Beirut – hanno promosso numerosi sforzi per garantire giustizia e diritti ai familiari. Tuttavia, a fronte dei continui ostacoli frapposti al lavoro di Bitar essi chiedono ora l’apertura di una inchiesta internazionale.
L’inchiesta interna avviata dalle autorità libanesi ha raggiunto l’apice del paradosso il 23 gennaio scorso, allorché il magistrato inquirente Tarek Bitar ha deciso unilateralmente di riprendere il suo lavoro dopo una sospensione di 13 mesi. Una interruzione legata alla quarantina di procedimenti giudiziari e richieste di ricusazione che ha dovuto fronteggiare e che ne hanno frenato il lavoro.
Bitar ha poi deciso di porre in stato di accusa otto persone, fra le quali vi è anche il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Ghassan Oueydate, e altri tre giudici. A loro viene ascritto il reato di “omicidio, incendio doloso e sabotaggio”. Indignato per gli addebiti rivolti, Oueydate ha immediatamente respinto le accuse e ha portato Bitar in tribunale per “insubordinazione”.
Con grande sorpresa, e derogando dalle sue prerogative, Oueydate ha poi ordinato il rilascio di 17 imputati che erano stati arrestati in varie fasi dell’indagine e che erano rimasti vanamente in attesa di processo. In quel frangente la polizia giudiziaria non ha osato disobbedire alle sue istruzioni. Tra gli imputati rilasciati vi era pure Mohammad Ziad el-Awf, direttore dell’ufficio di Sicurezza statale del porto di Beirut. Secondo gli osservatori, il rilascio è stato deciso su pressione degli Stati Uniti, perché l’imputato era in possesso di doppia nazionalità libanese e americana. Ciononostante, i parenti delle vittime ritengono che el-Awf sia una figura chiave dell’inchiesta perché sarebbe fra le persone a vario titolo “al corrente” del caso. E, da quel momento, l’indagine non ha più registrato ulteriori progressi e sembra essersi impantanata.